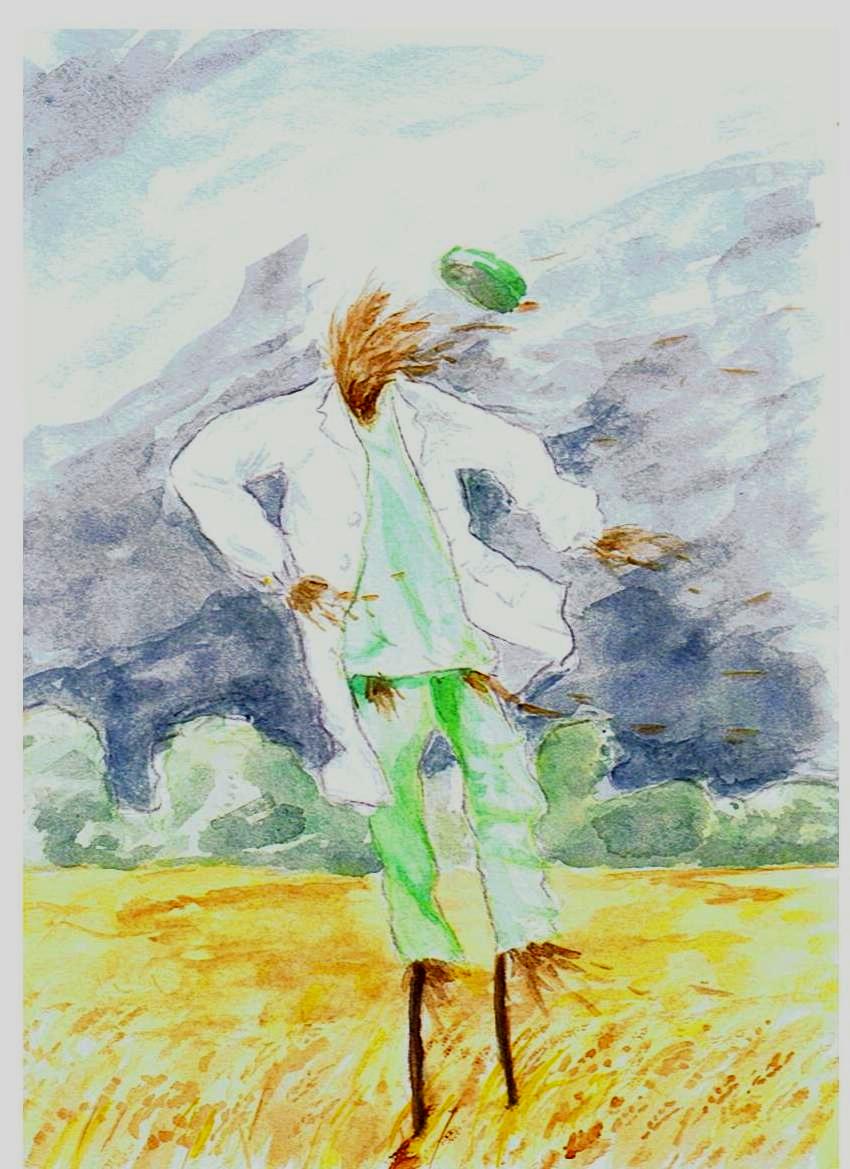foto di RR
Camera operatoria.
Si fa avanti un’infermiera. Sarà la mitica anestesista? Provo.
-Io vorrei l’anestesia totale, ma mi dicono che devo…- – deve parlare con l’anestesista!-
-Lo so! Rispondo secco. È lei?- – No-.
-Ma lei è teso-, mi dice con un sorriso dietro al simil-burka che le copre il viso -…cosa la turba?-
-Certo che sono teso, è da questa mattina che mi dicono di parlare con l’anestesista… esiste costui? È un terrestre? O è un fantasma?- rispondo un po’ incavolato.-Vede, è che vorrei… ma a che serve contarla a lei se devo parlare all’anestesista…-
-Ma no, mi racconti, mi racconti tutto…-
-È che vorrei l’anestesia totale e tutti mi guardano come fossi un marziano. Mica lo faccio per sfizio, è che è più forte di me, svengo se mi bucate la schiena.-
-Non se ne faccia un problema. Anch’io avrei paura, sa? Anch’io farei la totale, c’è niente di strano. Parli con l’anestesista e vedrà che vi mettete d’accordo.-
Che mi stia pigliando per il culo, mi chiedo… Ma quella mi sorride e mi dice che non vuole vedermi arrabbiato, che posso contare su di lei, che tutto si sistema. È una persona, e mi quieto. Avevo solo bisogno di un po’ di comprensione. Un pochino. Mi parla gentile, mi fa anche una carezza sul capo. Grazie, le dico, grazie.
Intanto si fa avanti un’altra infermiera, giovane, anche lei mascherata; mi buca il braccio e ci infila un chiodo per la flebo. Non una sillaba. Neanche fossi un legno o uno straccio. Ma a queste ragazze non l’ha mai detto nessuno che i malati sono anche persone? Lo sa quella fighetta risicata che fuori di qui me la trito in un baleno? Che non le lascio nemmeno il tempo di dire bah…
Arriva un tipo, un uomo questa volta, sempre mascherato. È così in quei posti, non vedi nessuno in faccia; oltretutto senza occhiali sono proprio orbo; se si ritraessero di un metro potrebbero farmi impunemente gli sberleffi.
-È lei l’anestesista-, chiedo?
-Si, che c’è?-
Infine eccolo qui, dunque, il mio arabo fenicio.
-Senta, io vorrei l’anestesia totale, l’ho già detto a tutto il mondo, e l’avevo detto anche al dottore che mi ha pronosticato il menisco rotto, ma lì c’è scritto che mi fate l’epidurale. E tutti m’hanno detto che devo parlare con lei…-
-E perché la vuole totale?- Mi chiede; ma è gentile, affabile. Forse è un furbone.
-Perché se no le resto in mano… svengo. Prima, sotto, ho già corso grossi rischi per il prelievo di sangue.-
-E come ha fatto?-
-Ho dovuto guardare via e farmi mettere un rattoppo sul braccio. Si figuri dunque se mi buca la schiena.-
-Beh, qui ha ancora meno problemi, allora, perché non può vedersi la schiena.-
Un altro che mi piglia per i fondelli, penso…
-Comunque se vuole io gliela faccio, la narcosi, ma non le conviene sa-, dice con calma. Mi parla anche lui come fossi una persona. –Oltretutto-, continua, -con l’epidurale dopo non ha male.-
-Dice bene lei, ma se le resto in mano?-
-Beh, siamo già qui… c’è tutto il necessario, cosa vuole di più?-
Bel merlo, penso, non c’è che dire. Però potrebbe anche esser vero quel che afferma, non è scritto che debba essere un serpente incantatore. Perché è davvero difficile essere bugiardi così bravi.
Un lampo, da pazzo, come spesso m’è successo: -dai, proviamo-, rispondo. Non so nemmeno io perché. Arriva l’infermiera umana, mi infila una siringa nel tubo predisposto da quell’altra e dice quasi con leggerezza: -questa le fa bene, è bella… è buona, è soltanto un calmante…- M’hanno incastrato come un pivello. Come un novellino; non di primo pelo, ma proprio sprovvisto, di pelo. Non dispongo più d’uno sputo di difesa.
Mi segano.
Mi spostano ancora, me e il letto. Mi fanno girare sul fianco destro e portare le gambe al petto. Braccia lunghe. Sono in due lì dietro. Sento pungere la schiena. Tutto lì? Però, una bazzecola, aveva ragione il tipo. Mi rigirano pancia al cielo. Poi mi alzano un telo davanti alla faccia. Bene, non voglio vedere. Dall’altra parte del telo parlano, muovono, non so cosa traffichino. Ogni tanto la fascia attorno al braccio sinistro si gonfia: controllano se son vivo, penso. Certo che son vivo!
Ma cosa combinano lì davanti? Che diavolo aspettano? Il tempo non passa, non m’accorgo nemmeno che non sento più la gamba.
Mi hanno messo addosso le coperte con la mano destra fuori, perché è quella impalata. La sinistra sotto, a non prendere freddo, allungata sul fianco. Mentre aspetto la mano si muove. Trova una massa molle, in mezzo alle gambe, senz’anima ne corpo, incoerente. Che diavolo è? M’han tirato fuori le trippe! Ma no… Sono i genitali! Realizzo di colpo. Possibile? Tocco meglio… non li riconosco, non hanno consistenza, come non fosse roba mia; eppure il salamotto piccolo piccolo sembra proprio lui, il fratellino…
Quando eravamo bambini e nessuno ci vedeva, toglievamo i vestiti alle bambole per vedere com’erano fatte in mezzo alla gambe; senza sapere cosa cercare, per altro, ma si cercava, la curiosità era prepotente; e non c’era niente. Nè pisello nè altro. Tutto liscio, tutto piallato, nulla. Ecco, io mi sono scoperto così, quando la mano è andata a spasso sotto le coperte.
Mi spostano ancora. Allora hanno finito. Mi fanno passare in una apertura strana per mettermi dalla lettiga a un’altra.
-Si sposti!-, mi incitano.
Macchè spostare, una parola, non risponde niente. Sono di piombo.
-Dai, forza!-, insistono.
Allora provo a rotolare. -No, non rotolando-, mi ammoniscono. E come faccio allora, maledizione? Poi ci arrivo. Punto sulle braccia e sposto la schiena sul lettino a fianco; qualcuno mi sposta le gambe. Si torna al mio letto. Non so chi mi porti, sono proprio cotto. Chissà che diavoleria m’han messo in vena…
La pipì.
Letto, Mil lì vicina che sorride.
La pace dopo la tempesta. Arriva un donnone e mi cambia il recipiente della flebo. Sarà un antidolorifico, penso. Per fortuna non c’è da bucare. Il buco è sempre quello della stronzetta di sopra.
-Appena fa pipì, la lasciamo andare-, dice il donnone.
Quanto ci vorrà?
Un paio d’ore.
Il tempo passa.
Ho modo di controllare tutto me stesso lì sotto, quel che sento e quel che non sento. Gamba destra assente, sinistra presente ma senza dita del piede, e gluteo che sembra un budino, una vescica tiepida, sorda come una ciocca. Ma non c’è dolore, è già qualcosa.
Flebo finita. La sostituiscono con un fiasco. Ci sarà un litro di brodo lì dentro. Per fare pipì. -Beva quattro bicchieri d’acqua-, ordina la tipa. Questo è facile, penso. E invece no. È difficilissimo bere stando orizzontale. Difatti non c’è nessun animale che beva così, in natura. Nemmeno le lucertole: pigliano una boccata e alzano il muso al cielo per mandarla giù.
Passa il tempo. Mil va a farsi un giro, è stanca e stufa ed ha ragione. Che palle aspettare che uno faccia pipì.
Entrano due ragazzette bianco vestite. -Ha urinato?- Esclama forte una. Avrà visto il grigio dei miei capelli e deciso che sono sordo. -No-, rispondo secco. Urinare, penso: dev’essere per darsi un tono… fatto pipì non va eh, troppo umano, ma vaff… anche tu, dai. Altro fiasco da mandare in vena.
Scoccano le due ore.
-Fatto pipì?-
-Macché!-
L’infermiera è un’altra. Ma quante ce ne sono? Sono tutte qui a scrutare le mie disgrazie?
Questa però mi piace. Giovane anche lei ma semplice e umana, sorride, ha un cuore e credo anche un’anima.
Quanto ci vorrà ancora? Mezz’ora e vedrà che arriva. E intanto cambia fiasco un’altra volta. E tre! Più il primo.
Due ore e mezza, niente.
Tre ore.
Quattro, tuoni e fulmini.
-Fatto pipì?- -Nooooooooooo!-
-Vedrà che adesso arriva-, dice sorridente l’infermiera. Venti minuti.
-Provi a sedersi sul letto con le gambe penzoloni-.
Aspetto un po’ poi Mil mi aiuta. Ma come si fa a fare pipì se non ti senti il pisello, accidenti? Eppure, tra fiaschi e bicchieri d’acqua, ne avrò bevuti dieci, non quattro, dovrà pur decidersi. È un’impresa persino infilare il pisello nel pappagallo: poveraccio lui, è mortificato, potesse rientra nell’antico vano assieme ai testicoli. Ma quando tutto sembra perso…
Pipìììììììììììììììììì………… poca, ma c’è.
Robe da matti. Sessant’anni per gioire d’un bicchiere di pipì! Troppo poca, dice l’infermiera, e mette su un altro fiasco. Con questo sono quattro. Ma ormai il ghiaccio è rotto. Sono le 19.00 suonate quando l’impresa ha termine, faccio di nuovo pipì e l’infermiera dice che possiamo andare. Schizzo sul letto.
-Non vuole mangiare qualcosa?-
Ma no… andiamo via subito.
-Mangi qualcosa…-
-Un frutto-, rispondo. C’è?
-Una mela cotta?-
Perfetto. Due mele cotte, una anche per mia moglie.
-Gliele porto, ma non devo farmi vedere-, dice il mio angelo.
Si vede che c’è qualche bastardo che controlla, penso, e magari il rancio non mi spetta. Trovarlo tra qualche tempo, il verme, magari al Lauzun o al Lubè… Mangio in un lampo, Mil non ha fame. Torna l’infermiera, mi insegna a farmi l’iniezione nella pancia da solo, a camminare con le stampelle, due dritte generali; la ringrazio con un sorriso da orecchio a orecchio, l’abbraccerei, le darei un bacio, tanta è la mia riconoscenza. Tutto il contrario di quanto provo per il Dottore che mi ha operato. Lui non m’ha detto nemmeno crepa, su in camera operatoria, nemmeno m’ha degnato d’uno sguardo; gli sarebbe bastato affacciarsi oltre il telo, ma forse pensava di operare un pupazzo. Di fare allenamento. Tanto meno s’è degnato di venirmi a vedere in camera. Sono singolari questi personaggi. Autentici luminari, bravissimi e senz’anima, vuoti come una vescica; sembrano il mio gluteo sinistro quando ancora era sotto effetto dell’anestetico: lo sentivo ballonzolare se lo scuotevo con la mano ma non sapeva di nulla e non diceva nulla. Una vescica. Gli stambecchi per i quali mi sono fatto male sono molto più espressivi, ed uguali quanto a parola, perché entrambi sono muti.
Ma ora è tutto passato. Si parte. Via!
Tutti in fila.
Da quell’ospedale là a casa ci sono una novantina di chilometri. È buio pesto ormai. Mil non ama guidare di notte, conosce poco la Polo che non usa mai, e non conosce il percorso. È tesa ma si và. Faccio il navigatore.
Tutto dritto, asciutto, non c’è nebbia. Mil guida impettita, dura a metà dello spazio tra il volante e il sedile. Se la si bucasse non uscirebbe una stilla di sangue. Cinquanta all’ora, ma si va. Dietro ci sono parecchie auto. Più grandi, più piccole, furgoni e camioncini. Mil ha messo tutti in riga. Chi ha la ventura di fare il nostro percorso, viaggia a cinquanta all’ora. Passano uno alla volta dove possono.
Da quell’ospedale là a casa. Eterno.
Vicino a casa Mil si rià, tocca punte anche di ottanta chilometri l’ora per qualche istante: lì conosce bene la strada; tiene duro, è davvero grande la mia Mil, e alle 21 siamo a casa. Dalle 6.30 del mattino.
È fatta. Siamo eroi.
E tutto per uno stupido menisco… una guarnizione, o poco più.
rens